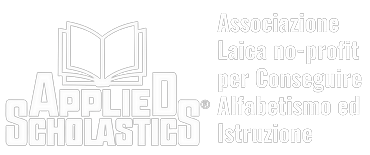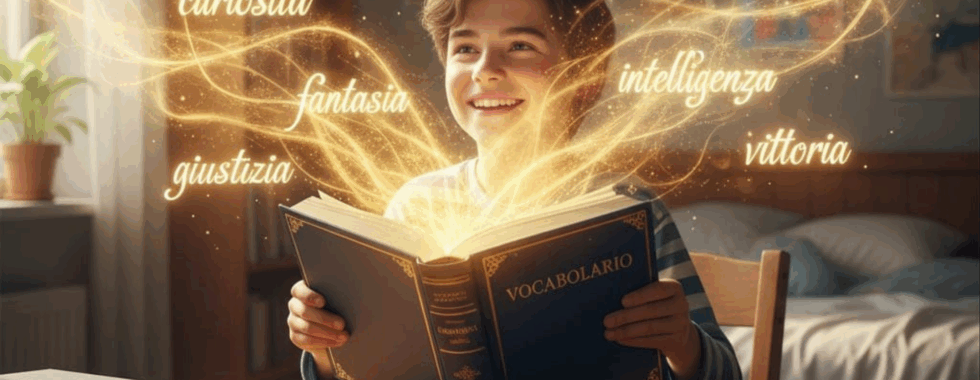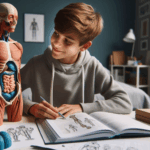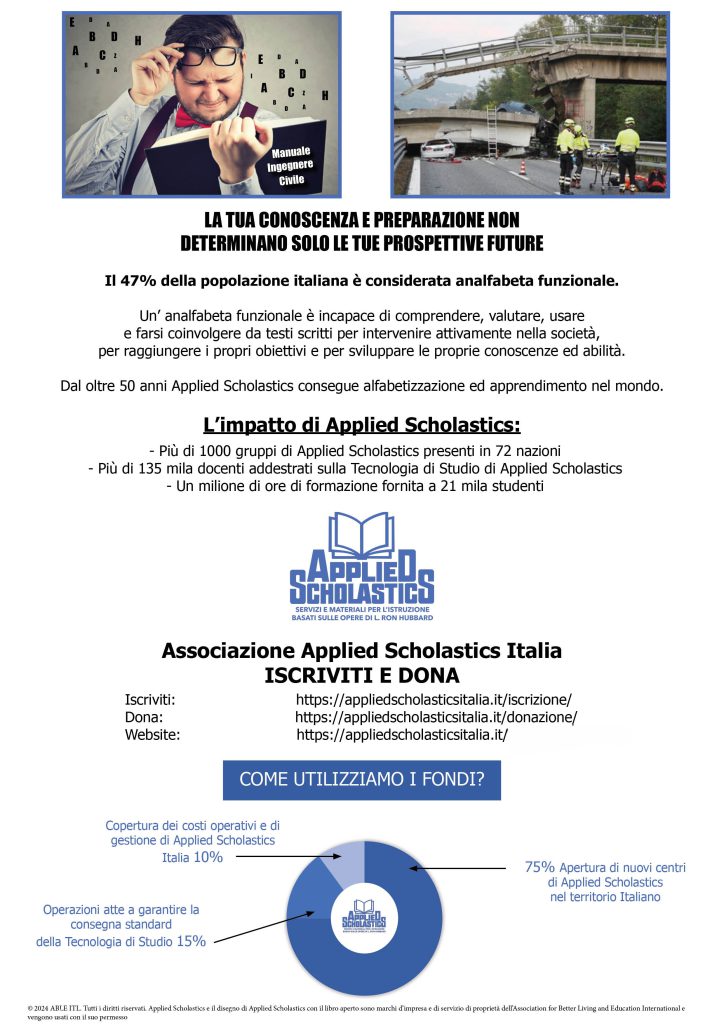IL RUOLO DELLE PAROLE NELLO STUDIO EFFICACE
PERCHÉ LA COMPRENSIONE DELLE PAROLE È LA CHIAVE DI UN APPRENDIMENTO DURATURO
L’enciclopedia Treccani definisce il verbo comprendere in questo modo: “accogliere nella mente, nell’intelletto, afferrare il senso di qualche cosa, stabilire una relazione tra più idee o fatti”.
La parola deriva dal latino ed è formata da cum (con) e prehendere (prendere). Letteralmente può essere intesa come “prendere insieme”, ma il suo significato è molto più profondo: prendere come includere, contenere. Quando una certa informazione è compresa, è quindi fatta propria, diventa in qualche modo parte di noi.
Sul sito di Applied Scholastics Italia, viene definita una parola mal compresa come “una parola che non si è capita o che si è capita male. Nel momento in cui si legge una parola che non si conosce o comprende si ha una sensazione di vuoto mentale e offuscamento, che può portare a una sensazione di vuoto, sfinimento e anche nervosismo isterico. Una parola mal compresa può bloccare completamente uno studente”.
Quando, leggendo un testo, incontriamo una parola che non è stata perfettamente compresa, quando cioè, in senso figurato, non la sentiamo davvero interiorizzata, le conseguenze possono essere catastrofiche per quanto riguarda il resto della nostra lettura.
Gli effetti di tutto ciò sono ben visibili tutti i giorni, per esempio quando uno studente si lamenta del fatto di studiare molto, ma di arrivare a fine giornata e non ricordarsi nulla.
LE MALCOMPRENSIONI SECONDO LA LETTERATURA SCIENTIFICA
Come per le altre barriere allo studio, anche in questo caso sono numerose le evidenze scientifiche che ne confermano i principi.
Vediamone alcune.
L’importanza del vocabolario nella comprensione
Grazie agli studi di Nation¹ (1990, 2006) è emerso quanto sia importante avere un buon vocabolario, cioè conoscere il significato di una buona quantità di termini.
La sua teoria prende il nome di Ipotesi della Soglia Lessicale (Lexical Threshold Hypothesis) ed afferma che un lettore debba conoscere una certa percentuale di parole all’interno di un testo al fine di poterlo comprendere in modo adeguato.
Quando tale percentuale scende al di sotto di questa soglia, la comprensione viene drasticamente compromessa.
Secondo questo studio, sarebbe necessaria una percentuale di parole note pari al 95-98% per avere una comprensione completa.
Saltare le parole sconosciute diventerebbe quindi un’azione dannosa, perché impedirebbe di afferrare il significato generale del testo.
Una parola sconosciuta può bloccare la lettura
Secondo la ricerca in psicologia cognitiva e linguistica, la lettura non è un processo lineare, dove la decodifica è seguita automaticamente da comprensione. Si tratta piuttosto di un’interazione costante tra:
- decodifica delle parole
- accesso al lessico
- uso delle conoscenze pregresse
Linnea C. Ehri² (1998) afferma che, quando si incontra una parola sconosciuta, tale processo si interrompe. Se la parola non viene chiarita, il lettore deve mantenere una lacuna di significato nella memoria. Parola dopo parola, la memoria diventa sovraccaricata da troppe informazioni non risolte, non riesce a integrarle con le nuove e la traccia mnestica dell’intero passaggio si deteriora o si perde completamente.
La difficoltà, dunque, non è solo non conoscere la singola parola, ma il fatto che il blocco su quella parola andrà poi a compromettere l’intera costruzione del significato.
Che cos’è l’inferenza lessicale e quanto è rischiosa
Haastrup³ (1991) ha indagato a fondo gli effetti dell’inferenza lessicale, cioè quel processo che consiste nel dedurre il significato di una parola sconosciuta basandosi sul contesto e sulle proprie conoscenze pregresse.
Con l’obiettivo di esaminarne l’affidabilità, ha evidenziato che si tratta di una delle strategie più frequentemente adottate, in particolare nell’apprendimento delle lingue straniere. Tuttavia, non sempre è efficace: quando l’inferenza è errata, può compromettere la comprensione dell’intero testo, alterandone il significato.
Studi successivi, come quello di Hu⁴ & Nassaji⁵ (2014), hanno dimostrato che un’inferenza sbagliata o fallita (cioè quando il significato non viene dedotto) è meno facilmente memorizzata rispetto a un concetto chiarito, influenzando negativamente l’apprendimento del vocabolario.
Gli studenti più competenti tendono a monitorare e correggere le proprie inferenze, mentre quelli meno esperti non verificano le ipotesi, aumentando il rischio di consolidare gli errori.
Il ruolo del glossario nella comprensione del testo
L’inserimento di un glossario all’interno di un testo può facilitare l’apprendimento e migliorare la comprensione generale.
Nation, nel suo libro Learning Vocabulary in Another Language (2001), sottolinea che i glossari sono particolarmente utili nei testi specialistici, o per gli studenti di lingue, poiché riducono il carico cognitivo e favoriscono l’autonomia nella decodifica dei termini.
In particolare, distingue tra glossari generali (con definizioni standard) e glossari contestualizzati (legati al contenuto specifico del testo), suggerendo che questi ultimi siano più efficaci per la comprensione.
Nel 1997, Laufer⁶ e Hadar⁷ pubblicano sul Modern Language Journal l’articolo intitolato Assessing the Effectiveness of Glosses. Tale studio dimostra che l’efficacia dei glossari nel supportare l’apprendimento del vocabolario dipende dalla loro struttura e dal tipo di informazioni offerte. Glossari chiari, ben organizzati e facilmente consultabili favoriscono la comprensione e la memorizzazione dei significati delle parole.
In particolare, avendo preso in considerazione l’apprendimento di una lingua straniera, quelli che combinano traduzione e spiegazione contestuale risultano particolarmente utili per gli studenti, poiché facilitano sia la comprensione passiva che l’uso attivo del lessico.
Quest’ultimo punto è confermato da Jacobs⁸, Dufon⁹ e Fong¹⁰ (1994), i quali aggiungono che l’efficacia del glossario dipende anche dalla motivazione del lettore e dalla semplicità con cui vengono spiegati i termini: quando le parole sono chiarite in modo semplice e contestualizzato, l’apprendimento è più duraturo.
Un buon uso del vocabolario è alla base della comprensione
Nel suo contributo Vocabolario e comprensione del testo (2020), Lorena Montesano¹¹ sottolinea come la padronanza del lessico sia un elemento centrale per la costruzione del significato durante la lettura. Secondo l’autrice, non è sufficiente conoscere molte parole: è fondamentale riflettere sul loro significato, coglierne le sfumature e saperle usare in modo consapevole.
La comprensione profonda di un testo, infatti, dipende dalla capacità di attivare e collegare conoscenze lessicali pregresse. Montesano evidenzia che il vocabolario non deve essere inteso come semplice elenco di termini da memorizzare, ma come uno strumento cognitivo che permette di costruire rappresentazioni mentali coerenti e stabili.
Per questo motivo, promuovere attività didattiche che stimolino la riflessione sul significato delle parole è essenziale per potenziare la comprensione e l’apprendimento.
La comprensione del testo richiede attenzione, riflessione e una buona padronanza del vocabolario.
Come dimostrato, ignorare una parola sconosciuta, o affidarsi a inferenze imprecise, può compromettere l’intera costruzione del significato.
L’uso consapevole di strumenti come il vocabolario si rivela fondamentale per superare la barriera allo studio che prende il nome di parola mal compresa.
Chiarire bene le parole è fondamentale per rendere l’apprendimento davvero facile e duraturo.
Dott.ssa Laura Leonardi
Note:
¹ Ian Stephen Paul Nation (1944). Professore emerito presso la Victoria University di Wellington. Studioso nel campo della linguistica e della metodologia didattica. Le sue ricerche hanno contribuito in modo significativo alla comprensione dell’acquisizione del vocabolario e all’analisi della frequenza lessicale.
² Linnea C. Ehri (1936). Psicologa e linguista statunitense. Professoressa emerita di psicologia dell’educazione presso il Graduate Center della City University di New York (CUNY). Considerata una delle massime autorità nello studio dei processi di riconoscimento delle parole e nell’acquisizione dell’abilità di lettura.
³ Kirsten Haastrup (1939-2011). Linguista danese. Professoressa emerita presso la Copenhagen Business School. La sua ricerca si focalizza sull’acquisizione e l’uso del vocabolario nelle lingue straniere, in particolare sulle strategie di problem-solving usate dagli studenti per dedurre il significato delle parole sconosciute.
⁴ Hsueh-chao Marcella Hu. È professoressa associata presso l’Overseas Chinese University. I suoi interessi di ricerca includono l’insegnamento e l’apprendimento del vocabolario.
⁵ Hossein Nassaji (1960). Linguista e metodologo canadese di origine iraniana. Professore presso l’Università di Victoria, (British Columbia, Canada). Le sue ricerche riguardano la linguistica applicata nell’acquisizione della seconda lingua, con focus sull’interazione in classe e il feedback correttivo.
⁶ Batia Laufer. Psicolinguista e studiosa israeliana. Professoressa emerita presso l’Università di Haifa. I suoi studi si occupano di ricerca sull’acquisizione della seconda lingua, in particolare sull’acquisizione del vocabolario. Oltre ciò, approfondisce tematiche nello studio delle lingue, come la competenza lessicale e produttiva.
⁷ Hadar Netz. Linguista e ricercatrice israeliana, Membro della Facoltà presso la School of Education dell’Università di Tel Aviv. I suoi lavori si occupano di analisi del discorso e pragmatica nell’acquisizione del linguaggio, con attenzione al ruolo dell’interazione in classe e alla comunicazione digitale.
⁸ George M. Jacobs (1952). Educatore statunitense. Professore emerito presso la University of Hawaii. I suoi studi riguardano l’acquisizione della seconda lingua, l’apprendimento cooperativo e del glossing (note a margine) come strategia di lettura.
⁹ Peggy Dufon. Dottoranda presso il Dipartimento di Inglese come Seconda Lingua presso la University of Hawaii di Manoa. I suoi interessi di ricerca includono il ruolo della pragmatica nell’acquisizione della seconda lingua.
¹⁰ Fong Cheng Hong. Dottoranda presso il Dipartimento di Economia University of Hawaii di Manoa e ricercatrice economista presso JP Morgan Securities Asia. I suoi interessi di ricerca includono l’analisi statistica.
¹¹ Lorena Montesano. Psicologa e didatta italiana. Docente a contratto presso l’Università della Calabria. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano la didattica speciale e l’inclusione scolastica, con particolare attenzione alla diagnosi e alla riabilitazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.